Dettagli delle lezioni
| ------------- | ------------- | 1. Gio 29/02 |
| 2. Lun 4/03 | 3. Mar 5/03 | 4. Gio 7/03 |
| 5. Lun 11/03 | 6. Mar 12/03 | 7. Gio 14/03 |
| 8. Lun 18/03 | 9. Mar 19/03 | 10. Gio 21/03 |
| 11. Lun 25/03 | 12. Mar 26/03 | ------------- |
| ------------- | ------------- | 13. Gio 4/04 |
| 14. Lun 8/04 | 15. Mar 9/04 | 16. Gio 11/04 |
| 17. Lun 15/04 | 18. Mar 16/04 | 19. Gio 18/04 |
| 20. Lun 22/04 | 21. Mar 23/04 | ------------- |
| 22. Lun 29/04 | 23. Mar 30/04 | 24. Gio 2/05 |
| 25. Lun 6/05 | 26. Mar 7/05 | 27. Gio 9/05 |
| 28. Lun 13/05 | 29. Mar 14/05 | 30. Gio 16/05 |
| 31. Lun 20/05 | 32. Mar 21/05 | 33. Gio 22/05 |
| 34. Lun 27/05 | |
35. Gio 30/05 |
| 36. Lun 3/06 | ------------- | ------------- |
[Esami (date scritti): 17 giugno e 4 luglio; 9 e 18 settembre]
[Galleria di immagini e link associati]
- Lezione 1 (29/02, 2h)
-
- Informazioni generali sul corso
- Impostazione del corso
- Orario
- Modalità d'esame
- Questioni matematiche preliminari:
- Derivate
- notazione di Leibniz delle derivate;
- derivate parziali
È importante quindi cominciare a imparare che- in Fisica e in tutte le Scienze, una grandezza di interesse può essere funzione di una o più grandezze aventi in genere anche delle unità di misura.
- in genere può avere interesse di capire come varia la funzione rispetto
a una sola delle altre,
lasciando le rimanenti invariate, da cui il concetto di derivata parziale (la voce italiana è pessima...).
- derivative of 5 x^2
- derivative of m x^2 [da notare come nella risposta è cambiato il simbolo di derivata!]
- derivative of m x^2 wrt m
- derivative of m x^2 y^3 wrt y
- derivative of A cos(omega t + phi)
→ Wolfram Alpha è in grado di capire che in una funzione del genere la variabile 'di interesse' (di default) è t
anche se gli si può indicare esplicitamente rispetto a cosa derivare, ad es:
- Integrali
- Può aiutare capire che l'integrale indefinito
altro non è che l'operatore inverso della derivata
('antiderivata', anche se dalle nostre parti questo termine sembra sconosciuto)
e anche qui ci aiuta Wolfram Alpha: - Per quanto riguarda gli integrali definiti:
- va ricordato che (praticamente sempre in Fisica!) non sono semplicemente 'aree',
- bensì la somma di infiniti elementi infinitesimi
(si riducono ad aree nel caso particolare in cui si sommano aree infinitesime).
- Bisogna saper fare, almeno per questo corso, gli integrali di
- potenze;
- funzioni trigonometriche elementari;
- esponenziali
- Nella vita pratica spesso gli integrali non si riescono a
risolvere esattamente ('analiticamente') e si deve ricorrere
- a Mathematica o Wolfram Alpha (o equivalenti — una volta si usavano appositi almanacchi);
- a metodi numerici in cui, al posto della somma di infiniti elementi infinitesimi, se esegua la somma di 'tanti' termini sufficientemente 'piccoli';
- ai cosiddetti metodi di Monte Carlo (vedi Galleria)
- Può aiutare capire che l'integrale indefinito
altro non è che l'operatore inverso della derivata
- Derivate
- Test di autovalutazione:
- Informazioni generali sul corso
- Lezione 2 (4/03, 3h)
-
- All models are wrong, but some are useful (ci ritorneremo)
- Filo conduttore delle prime lezioni: misure di densità: da piccoli oggetti a Terra e Luna
- Discussione dei quesiti del test di autovalutazione
- Nel corso si terrà conto della diversa provenienza degli studenti.
- Radici e logaritmi come 'operazioni inverse' delle potenze,
ovvero a partire da ab=c:
- (a,b) → c ↠ potenza;
- (b,c) → a ↠ radice;
- (a,c) → b ↠ logaritmo.
(cosa che si può fare facilmente giocando con interi) e un altro è fare i conti (ma fortunatamente oggigiorno calcolatrici e computer ci fanno il 'lavoro sporco'). - ↠ vedi quesito 10.
- Per capire bene la questione ricordarsi che per ottenere il valore
aumentato del 10% occorre moltiplicarlo per 1.1;
quello aumentato del 20% occorre moltiplicarlo per 1.2, etc. etc. - L'importanza di questo quesito è imparare a ragionare
con la dipendenza dalle potenze delle grandezze in gioco:
V = A×h ∝ R2×h ∝ d2×h. - Quesito concettualmente simile al precedente, con
m = ρ×V ∝ ρ×l3. - Quesito concettualmente simile ai precedenti, con
V ∝ R3
A ∝ R2
↠ V ∝ Aα (valore della potenza α lasciato come esercizio) - Semplici formule inverse, ma occasione per
- ricordare la forza di gravità fra oggetti 'puntiformi' (o sferici omogenei — ci ritorneremo);
- far notare l'analogia con l'espressione della forza di Coulomb;
- introdurre il concetto di massa gravitazionale (una specie di 'carica'),
contrapposto a quello di massa inerziale che compare in a = F/m.
- Occasione per
- ricordare la relazione fra esponenziale e logaritmo;
- ricordare che le funzioni exp(), log(), sin(), cos(), etc.
- vogliono argomenti adimensionali ('numeri puri');
- 'ritornano' (nel senso informatico) numeri puri.
- far notare come in Fisica si possono uguagliare
solo grandezze dimensionalmente omogenee
(in questo caso abbiamo dei 'Volt' in entrambi i membri).
- 'Soluzione' del quesito nr. 3.
Le virgolette stanno a indicare che il lavoro non è finito,
ma curiosamente capitano studenti universitari che sanno risolvere
questa equazione, ma non la sanno impostare a partire dal quesito del mattone (!!). - 0.85 × 1.15 = 0.986 < 1 (!)
- Semplice esercizio sulle derivate, ma sapere quale
equazione soddisfa
la relazione richiesta è di fondamentale imporanza per tante applicazioni. - Idem
- Questo quesito ci riconduce al precedente
- Classico problema, da vedere come discretizzazione di un esponenziale.
- 'Banale' addendum al quesito precedente.
- Politici e giornalisti opterebbero per la A.

Qui la questione è decidere fra C e D, come discusso a lezione. - Facile quesito, a parte precisare che si intendeva, 'ovviamente', il valore assoluto della velocità.
- Fare attenzione a non confoderlo con la variante
di metà tempo di percorrenza a v1 e metà tempo a v2.
↠ Scrivere l'espressione di velocità media nei due casi, etc.
Risultati in termini di medie:- il quesito originale dà luogo a una media armonica;
- la variante dà luogo alla media aritmetica.
- Interessante problema legato alla ben nota spinta di Archimede:
- Quanta acqua 'del bicchiere' sposta l'acqua ghiacciata ('cubetti')?
- E quanta ne sposta quando si è sciolta?
- Un canottino con a bordo una 'incudine' è a galla sull'acqua di una piscina.
Successivamente l'incudine viene rimossa dal canottino e lasciata affondare.
Dire se ed eventualmente come varia il livello dell'acqua della piscina.
- → prossime lezioni
- → prossime lezioni
- Presentazione del formulario del corso,
approfittando per parlare di- Basi di cinematica (limitatamente alle prime 4 equazioni del paragrafo);
- secondo principio, espresso come a=F/m e come dp/dt = F,
da trasformare in termini vettoriali
(prime due equazioni del paragrafo Leggi della meccanica)
le tre componenti x, y e z di spostamento, velocità, accelerazione, forza e quantità di moto. Poi approfondiremo - Massa inerziale (quella che compare in a=F/m) e massa gravitazionale (vedi sopra).
Problemi proposti (*)- Quesito nr. 19
- arrivando prima alla 'formula risolutrice' (senza valori numerici),
- sostituendo successivamente i valori numerici
- e trattando algebricamente le unità di misura (che non vanno 'inventate' sapendo cosa ci si aspetta).
- Variante nel quesito precedente, con n intervalli temporali Δti,
ciascuno percorso con velocità vi (solo formula risolutrice).
Come si interpreta la formula che si ottiene? - Problema di una velocità (lungo x) che varia nel tempo secondo un esponenziale decrescente,
ovvero vx(t) = vx0e-t/τ, con- vx0 = vx(t=0) = 100 km/h;
- τ = 1' (ovvero 60s).
- Calcolare il valore della velocità per t=0, t=τ, t=2τ e t=5τ, t=10τ.
- Valutare l'espressione dell'accelerazione in funzione del tempo, ovvero ax(t).
- Calcolare il valore dell'accelerazione (con il segno corretto!) per t=0, t=τ, t=2τ, t=5τ e t=10τ.
- Calcolare l'espressione dello spazio percorso da t=0 al generico t, ovvero di x(t), avendo posto x(t=0)=0.
- Calcolare l'espressione di x(t) per t=τ, t=2τ, t=5τ e t → ∞.
- Plottare con il programma di grafica preferito vx(t), ax(t) e x(t) da t=0 a t=5τ.
(saranno fornite ulteriori informazioni e raccomandazioni).
E, ovviamente, non per domani...] - Lezione 3 (5/03, 2h)
-
"All models are wrong, but some are useful" (G. Cox)
- Vettori
- per come sono stati introdotti, per ora sono
solo una specie di 'notazione compatta'
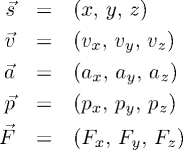
- Grandezze vettoriali (caratterizzate da modulo, direzione e verso) e grandezze scalari.
- Richiami delle basi di trigonometria, a partire dai triangoli rettangoli simili.
- per come sono stati introdotti, per ora sono
solo una specie di 'notazione compatta'
- E, a proposito di triangoli simili (in generale)
→ misure mediante 'triangolazione': ↠ esempi in Galleria
↠ diametri angolari (soprattutto di corpi celesti) - Nota sulle variazioni di posizione e velocità
sommando infiniti termini infinitesimi
- variazine di posizione (nello spazio, per fare il caso più generale):
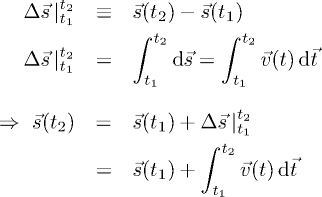
- variazione di velocità, sempre in 3D:
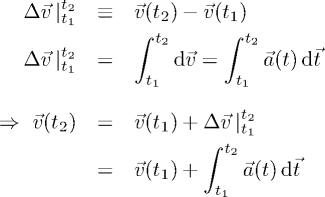
- variazine di posizione (nello spazio, per fare il caso più generale):
- Problema tipico, indicando ora con t0
l'istante iniziale
(al posto di 't1 delle formule sopra)
e con 't' il generico tempo (attenzione quindi alle variabili di integrazione!)
— dati (usando il grassetto per denotare i vettori)- la posizione iniziale s(t=0);
- la velocità iniziale v(t=0);
- l'accelerazione in funzione del tempo a(t) [spesso costante, nei problemi elementari],
↠ → v(t) [ovvero vx(t), vy(t) e vz(t)];
↠ → s(t) [ovvero x(t), y(t) e z(t)] - Equazioni orarie e traiettorie:
- le equazioni orarie sono semplicemente, in coordinate cartesiane, x(t), y(t) e z(t)
(per il momento — poi incontreremo anche 'coordinate polari'); - le traiettorie rappresentano invece, per dirlo alla buona,
i percorsi compiuti dal 'punto materiale' nello spazio:
↠ nel caso bidimensionale, che è il solo che analizzeremo:- la traiettoria è data semplicemente dalla curva y(x);
- essa si ottiene dalle equazioni orarie x(t) e y(t)
- invertendo x(t) → t(x);
- sostituendo 't(x)' in y(t).
- le equazioni orarie sono semplicemente, in coordinate cartesiane, x(t), y(t) e z(t)
- Dettagli sulla forza di gravità:
- Forza di Newton fra due 'punti materiali'
(la ben nota formula con d2 al denominatore).
Qual'era, secondo Newton, la causa della forza di gravità?
↠ Newton si astenne: "Hypotheses non fingo"
↠ (come la racconta Gabriele Ghisellini su Youtube) - Forza di Newton fra un corpo sferico omogeneo e un punto materiale posto fuori
di esso:
→ come se l'intera massa della sfera fosse nel suo centro!
→ vedi Galleria per avere un'idea (senza dimostrazione).
- Estensione a due corpi sferici omogenei:
→ come se la massa fosse concentrata al centro di ciascuno;
→ 'd' che compare nella formula è la distanza fra i due centri. - Caso particolare di 'punto materiale' sulla superficie → la ben nota formula con RT2 al denominatore.
- Forza per unità di massa di un oggetto in prossimità della superficie terrestre:
- g = G MT / RT2:
- interpretabile come accelerazione nel caso di un corpo in ideale caduta libera,
- ma, più in generale, è la forza gravitazionale per unità di massa:
- vale quindi, approssimativamente 9.8 N/kg;
- da cui segue che la forza gravitazionale vale mg.
pari a mg e diretta verso il basso, ma non ha nessuna accelerazione!)
- g = G MT / RT2:
- Forza di gravità e accelerazione di caduta libera
dalla superficie terrestre alla quota delle Stazione Orbitale ISS
.. alla Luna. - Spazio di caduta libera (proposto come esercizio):
- in prossimità della superficie terrestre;
- alla quota della ISS;
- per la Luna.
- Perché le mele cadono e la Luna gira se la forza di gravità è la stessa?
↠ cannone di Newton - Nota sulla famosa '9.8 m/s2':
→ si capisce meglio se si rilegge come '(9.8 m/s)/s'.
- Forza di Newton fra due 'punti materiali'
(la ben nota formula con d2 al denominatore).
- Più forze agenti sullo stesso oggetto: semplicemente si sommano vettorialmente.
- Quesito nr. 22 del test di autovalutazione:
Non confondere- forze di diversi 'agenti' sullo stesso corpo e che danno risultante nulla
(es. forza di gravità e reazione vincolare di un oggetto fermo su un tavolo)
con - forze uguali e contrarie secondo il Terzo Principio di Newton (di azione e reazione ).
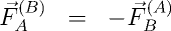
Chiara ora la risposta al quesito?
Nota: il caso 1. corrisponde invece a ,
ovvero
,
ovvero 
- forze di diversi 'agenti' sullo stesso corpo e che danno risultante nulla
- En passant, importanti approssimazioni che ci sono servite
per arrivare a una formula 'decente', benché approssimata, per gISS:- (1+ε)2 ≈ 1+2ε
[e, ovviamente, (1-ε)2 ≈ 1-2ε]; - 1/(1+ε) ≈ 1-ε
[e, ovviamente, 1/(1-ε) ≈ 1+ε],
[Per farsi un'idea pratica, provare con 1.022, 0.972, 1/0.95, 1/1.04, etc.]
Inoltre, va da sé che, come inversa dell'approssimazione 1., si ottiene
— sqrt(1+ε) ≈ 1 + ε/2
— sqrt(1-ε) ≈ 1 - ε/2
(provare con qualche esempio numerico) - (1+ε)2 ≈ 1+2ε
Problemi proposti- Risolvere il problema della distanza da cui è stato fotografato
il Cupolone (→ Galleria)
- Supponendo che ad un certo istante (t=0) un oggetto
- si trovi in (x0, y0)
- abbia una velocità iniziale (vx0, vy0)
- e per t≥0 sia abbia una accelerazione costante (ax, ay),
- l'espressione delle componenti della velocità al generico t≥0;
- le quazioni orarie x(t) e y(t).
- Caso particolare della soluzione del problema precedente:
- moto unidimensionale verticale, a cui associeremo l'asse cartesiano x, diretto per comodità verso il basso;
- condizioni iniziali: x0=0 e vx0=0;
- accelerazione costante ax=g (la ben nota 'g').
- Ricavarsi le espressioni di
- vx(t);
- x(t).
- Usando il valore numerico g=9.8 m/s2 ricavarsi
- la velocità a t=1s, t=2s e t=3s;
- la posizione a t=1s, t=2s e t=3s.
- Altro caso particolare:
- moto bidimensionale, con l'asse x disposto orizzontalmente e l'asse y verticalmente e diretto verso l'alto;
- posizione iniziale nell'origine: x0=0 e y0=0;
- velocità iniziali vx0 e vy0;
- accelerazione costante con ax=0 e ay=-g.
- Riscrivere le espressioni generali di velocità e posizione, ricavate precedentemente, per questo caso particolare.
- Ricavarsi le espressioni del tempo t che soddisfano alle seguenti condizioni:
- v(t)=0 (indicare questo tempo con il simbolo tM);
- y(t)=0 (indicare la soluzione 'non banale' con tG).
- Ricavarsi le espressioni di x(t=tM) e x(t=tG).
- Calcolarsi le soluzioni numeriche dei quesiti 2 e 3 per vx0=vy0=10m/s.
- Dalle espressioni di x(t) e di y(t) ricavate nel problema precedente (punto 1.),
↠ trovare l'equazione della traiettoria, ovvero y(x).
- Un escursionista tende il braccio in una certa direzione, tenendo il pollice verticale.
Così facendo, il pollice copre esattamente un'auto in lontananza, posta trasversalmente alla direzione di vista.
Sapendo che la larghezza del pollice è di 2.2 cm, la sua distanza dall'occhio è di 59 cm
e che la lunghezza dell'auto è di 4 m, si valuti a che distanza dall'escursionista si trova l'auto.
- Vettori
- Lezione 4 (7/03, 2h)
-
- Precisazione di 'punto materiale'.
- Analisi qualitativa della palla lanciata verso l'alto:
- accelerazione durante il 'volo' (da quando si stacca dalla mano a quando viene ripresa);
- velocità (qui è importante non confonderla con il modulo!).
- Definizione 'naturale' di angolo in radianti (adimensionali!):
"arco su raggio".
Trasformazione grado <-> radiante: ricordare che le librerie scientifiche vogliono i gradi in radianti! - Moto di un punto materiale su un cerchio in coordinate cartesiane:

- si vede a occhio come il vettore r ruota, senza cambiare nel tempo il suo modulo.
- Calcolare velocità e accelerazione (sia
componenti cartesiane che moduli è un semplice esercizio:
→ da fare (e solo dopo discuteremo i risultati ottenuti).
- Calcolo di volumi sommando 'infinite fette di spessore infinitesimo':
- esercizi svolti a lezione per cilindro e cono;
- fare come esercizio il caso della sfera, usando il trucco di calcolare il volume di metà sfera (→ Galleria)
- Semplice misure(*) di massa mediante bilancia: principio di misura
[(*) Nota: i fisici italiani in genere preferiscono 'misura' al 'misurazione', ad "misura della massa dell'Higgs". Ma basta capirsi] - Misure di volumi di solidi regolari, mediante le ben note formule della geometria.
- Caso di solidi irregolare: Dato mancante per valutare la densità della maniglietta: m = 82.27 g.
- Cifre significative e loro 'propagazione' (misure dirette → misure indirette):
→ provare a vedere cosa succede costruendo la tabella suggerita a lezione
- regoletta pratica per moltiplicazioni e divisioni;
- regoletta pratica per addizioni e sottrazioni.
- Elementi di metrologia
- Misure (o misurazioni — 'measurements' in inglese):
- dirette (ad es. misure di massa con bilancia o misure di dimensioni di oggetti(*) con righello/calibro);
- indirette (ad es. misure di volumi e di densità).
- le misure dirette effettuate 'per confronto' (ad es. righelli o bilance classiche a due bracci) rappresentano solo casi particolari;
- l'uso di modelli geometrici (idealizzati!) fa parte della modellizzazione.
- Principio di misura ('fisico', 'chimico', etc.),
con esempi nel caso di termometri:- dilatazione di corpi;
- variazione di proprietà elettriche o elettroniche;
- variazione dello spettro di radiazioni elettromagnetiche.
- Sensibilità (da non confondersi con la 'risoluzione'!):
→ indica (in modo quantitativo) quanto la variazione dello 'stimolo fisico' (es. di temperatura), In,
fa variare il valore numerico Out che si 'legge' sullo strumento (ad es. innalzamento della colonnina di mercurio):
↠ dOut/dIn.
Un caso che abbiamo visto a lezione è quello della misura di un volume mediante innalzamento del livello dell'acqua:
→ Minore è il diametro del recipiente, maggiore è la sensibilità
in quanto una piccola variazione di volume causa una percepibile variazione di livello
(Si pensi cosa succede se immergiamo la maniglietta usata a lezione in una piscina!) - Interpolazione fra le tacche nella lettura
di strumenti analogici:
- sforzarsi di leggere al meglio;
- dipende dalle condizioni di lavoro e dagli oggetti da misurare;
- le regole 'scolatiche' dogmatiche di ±1 divisione o
±1/2 sono dovute a
curiose propagazioni di errori concettuali nella didattica e vanno evitate.
- Misure (o misurazioni — 'measurements' in inglese):
- Breve digressione sulle cifre significative:
- innanzitutto il numero di cifre dopo la virgola non significano niente,
in quanto la virgola dipende dall'unità di misura usata, mentre il numero di cifre significative non dipende dall'unità di misura; - nelle misure dirette sforzarsi di leggere al meglio;
- nel caso di misure indirette, effettuate quindi effettuando
opportuni calcoli si usi un po' buonsenso,
aiutandosi anche dalle regolette empiriche illustrate a lezione per moltiplicazione/divisione e somma/differenza. - Per dettagli si veda qui (→ par. 3.4 della dispensa Le basi del metodo sperimentale).
- Ovviamente, si raccomanda di (eventualmente) correggere i risultati numerici ottenuti per le misure di densità.
- Inoltre, alla luce di queste considerazioni,
anche negli esercizi 'teorici',
ovvero in quelli che non sono basati su dati sperimentali,
si raccomanda di limitare a 2-3 il numero di cifre significative.
- innanzitutto il numero di cifre dopo la virgola non significano niente,
- È stata messa sul sito del corso una 'dispensetta':
Dispensa_1.pdf
(riadattata da corsi precedenti, con precisazioni su alcuni degli argomenti
svolti a lezione e con alcune 'cosette su cui torneremo.)
Problemi proposti- Velocità e accelerazione di un punto materiale avente x(t) e y(t) dati sopra.
- Ricavarsi la formula del volume di una sfera sommando infinti dischetti di spessore infinitesimo.
- Misurare la densità degli oggetti di cui abbiamo effettuato misure in aula.
- Ancora sul problema nr. 1, ricordando che per definizione
un 'versore' è pari al vettore diviso il suo modulo
(e quindi un versore ha modulo unitario e fornisce solo direzione e verso):- valutarsi i versori dei tre vettori del problema;
- disegnare su un grafico cartesiano i tre versori per
- t = 0 e t = π/(2ω)
→ cosa ci aspettiamo che avvenga quindi al generico tempo t?
- Lezione 5 (11/03, 3h)
-
- Problemi in corso: chiarimenti:
→ moto circolare uniforme - Perché è il gessetto a cadere verso la Terra e non la Terra a muoversi
verso il gessetto?
(Dire che "tutto è relativo" non è corretto: bisogna considerare le accelerazioni!)
↠ Forze uguali e opposte, ma accelerazioni inversamente proporzionali alle masse. - Ulteriore misura di densità:
- Densità della sfera di piombo, misurando il
volume mediante la reazione alla spinta di Archimede
Cosa cambia fra quando l'oggetto è in acqua, ma senza toccare il fondo, a quando lo tocca (non più sospeso). - blocco di polistirolo
→ nuovo elemento di complicazione del problema;
→ spinta di Archimede in aria: ad es. palloncini;
→ come mai è importante per il polistirolo e non per gli oggetti 'usuali'?
- Densità della sfera di piombo, misurando il
volume mediante la reazione alla spinta di Archimede
- Ancora sulla forza di Gravità
("Professore, ma allora veramente il gessetto esercita una pur minima forza sulla Terra?")- Ulteriore domanda al quesito nr. 8 del test di autovalutazione: → G;
- "L'uomo che pesò il mondo"
- Forza esercitata su un punto materiale posto all'interno della Terra:
indicando con r la sua distanza dal centro della Terra (supposta omogenea!(*))- conosciamo già quanto vale la forza dovuta alla sfera di raggio r;
- si tratta di capire il contributo della parte rimanente:
→infiniti gusci sferici concentrici: (↠ Galleria)
- Analisi del moto di un oggetto nell'ipotetico (ma istruttivo)
problema del pozzo per il centro della Terra:
- dipendenza della forza dalla distanza ('x') dal centro della Terra;
- a(r)=-(g/RT)·x;
- ma, riscrivendo l'accelerazione come derivata seconda di x rispettto al tempo,
ci riconduziamo al quesito nr 13 del test di autovalutazione. - Generica soluzione: x(t) = X·cos(ωt+φ), con
g/RT = ω2 e
in cui X e φ vanno ricavati dalle condizioni iniziali
[ovviamente anche la funzione seno soddisfa l'equazione: e allora? pensarci...]
Problemi proposti- Valutare la densità della sfera di piombo con le misure effettuate a lezione.
- Valutare la densità del blocco di polistirolo trascurando la spinta di Archimede dell'aria.
- Dalla densità dell'aria 'tipica' (→ Wiki), calcolarsi la spinta
di Archimede sul blocco di polistirolo
e quindi massa e densità corrette da tale effetto. - Come è stato ricordato alezione, la pressione atmosferica è dell'ordine
di 105 Pa, ovvero di ≈105 N/m2.
Da questo valore, e trascurando che il campo gravitazione diminuisce con l'altezza (ma il grosso dell'atmosfera è 'in basso'):- Ricavarsi il valore approssimativo della massa di aria di una colonna di 1 m2.
- Ricavarsi quindi il valore approssimativo della massa di aria dell'intera atmosfera terrestre.
- Problema dell'ipotetico pozzo per il centro della Terra, assumendo
che l'oggetto sia lasciato cadere in esso:
- dalle condizioni iniziali ("è lasciato cadere dalla superficie terrestre")
x(0) = RT
vx(0) = 0
→ si ricavino i parametri X e φ della soluzione generale (vedi sopra). - Dalla x(t) ottenuta nel punto precedente si ricavino quindi:
- vx(t);
- ax(t).
- Dire per quale t l'espressione di vx(t) ha il massimo
e quanto vale x in quell'istante.
(Il risultato dovrebbe concordare con quanto ci si attende intuitivamente.)
- dalle condizioni iniziali ("è lasciato cadere dalla superficie terrestre")
- Graficare i dati simulati degli affondamento al fine di ottenere una figura 'tipo' quella riportata in Galleria
- Problemi in corso: chiarimenti:
- Lezione 6 (12/03, 2h)
-
- Problemi in corso: chiarimenti vari
- Approssimazione per piccoli angoli di:
- seno, tangente e coseno;
- valutazione di dimensione angolare di oggetti.
- Vecchia dispensa:
lezioni.pdf
(Att: contiene alcuni refusi) - Cannone di Newton: condizione di orbita
radente:
- argomento geometrico → Galleria;
- argomento dinamico: → identificare la forza centripeta.
- Corpi in orbita (in approssimazione circolare):
→ Terza Legge di Keplero: Galleria
(vedi anche grafica riassuntiva dei corpi orbitanti intorno alla Terra)
Problemi proposti- Calcolare periodo e velocità di rotazione di
- oggetto in ipotetica orbita radente intorno alla Terra;
- stazione orbitale ISS (per i conti si assuma un valore nominale della quota di 400 km).
- I satelliti geostazionari hanno la caratteristica di avere
un periodo di rivoluzione intorno alla Terra
pari a quello di rotazione della Terra sul proprio asse.
In questo modo essi ci appaiono nel cielo sempre nella stessa posizione (vedi Galleria.)
Valutare- la loro distanza dal centro della Terra;
- la loro distanza dalla superficie terrestre.
- Calcolare la dimensione angolare con cui ci appare
la stazione orbitale
(assumendo, come ordine di grandezza, c he abbia una estensione di 100 m) quando- è 'circa' allo zenit (sulla nostra testa);
- la vediamo a un'altezza di circa 45 gradi rispetto al piano orizzontale.
- Dai risultati ottenuti nel punto precedente calcolarsi, per i due casi,
il rapporto fra la dimensione angolare della ISS e quella media della luna. - Si calcolino le velocità
- della Terra intorno al Sole (velocità media), esprimendola in km/s;
- della Luna intorno alla Terra (velocità media), esprimendola in km/s;
- di Roma intorno all'asse terrestre, esprimendola in km/h e m/s.
- Un punto materiale viaggia lungo una traiettoria rettilinea alla velocità costante di 1 m/s.
Ad un certo istante (t0=0) esso è soggetto a una accelerazione la quale- cresce linearmente con il tempo e raggiunge il massimo di 1 m/s2 per t1 = 2 s;
- da t1 decresce linearmente, fino ad annullarsi per t2 = 4 s.
è maggiore, minore o uguale a quella che aveva fino a t0.
[Nota: la risposta qualitativa ben argomentata è sufficiente, ma a chi avesse
difficoltà si raccomanda di affrontare il quesito quantitativamente,
a partire anche da una figura che riporti l'accelerazione in funzione del tempo.]
- Lezione 7 (14/03)
-
- Questioni sui problemi in corso.
- Qualcuno ha trascritto accuratamente i dati di
affondamento della maniglietta?
(Dalla foto della lavagna non si capisce bene — sbagliando s'impara...)
- Qualcuno ha trascritto accuratamente i dati di
affondamento della maniglietta?
- Introduzione alle forze dovute a spaghi e funi 'ideali'
(inestensibili e senza peso):
→ analisi delle forze su oggetto fermo su piano orizzontale, tirato orizzontalmente con uno spago. - Introduzione alle forze elastiche:
→ analisi delle forze su oggetto fermo su piano orizzontale,
→ tirato orizzontalmente con un elastico:
→ → la forza tirante 'si vede'. - Forza elastica (idealizzata): proporzionale all'allungamento.
Costante di proporzionalità 'k': costante elastica (N/m, etc.) - Tensioni ('T') di funi ideali ('inestensibili e senza peso')
e uso del Terzo Principio in problemi con oggetti tirati da altri.
Analisi del semplice caso punto materiale libero di muoversi (solo) verticalmente
e soggetto solo a forza peso e a T diretta verso l'alto. - Forza di attrito statica e dinamica:
- Analisi di oggetto sul tavolo tirato con spaghi e elastici:
→ forze di attrito, statico e dinamico:
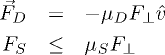
[Notare come, mentre per l'attrito dinamico essa viene data vettorialmente e in forma 'esatta',
nel caso statico viene dato solo il massimo valore che può raggiungere,
mentre direzione e verso sono opposti alla forza attiva che tira/spinge l'oggetto parallelmente alla superficie
(dire 'orizzontalmente' non è corretto: vedi ad es., sotto, analisi delle forze nel piano inclinato).] - Ruolo di carrucole ideali (senza attrito e senza inerzia) nei problemi elementari.
- Esempio di oggetto (1) sospeso e collegato mediante una 'fune'
passante per una carrucola
ad un altro (2) posto su un piano orizzontale.
Analisi delle forze e consequente accelerazione (comune!), date m1 e m2, in casi notevoli:- assenza di attrito: → a, T;
- attrito statico: → T
(e problemi collegati: ad es. rapporto m1/m2 affinché lattrito statico venga meno); - attrito dinamico: → a, T (+ 'quesiti inversi').
- Esempio di più corpi posti sul piano, uniti fra di loro da fili
e uniti, mediante carrucola, a corpo sospeso:- assenza di attrito: → a, T1, T2, etc.;
- attrito dinamico: → a, T1, T2, etc..
che tira il 'trenino' di masse collegate fra di loro.] - Ancora sui vettori, in particolare somma di vettori:
- si sommano le componenti cartesione;
- visione geometrica (famosa 'regola del parallelogramma').
- Piani inclinati 'ideali' (non si flettono e non si sfondano!):
- cenni agli esperimenti di Galileo (→ Galleria);
- scomposizione della forza peso;
- semplici problemi
- in assenza di attrito fra corpo che scivola(*) e piano;
- con attrito dinamico;
- con attrito statico: angolo massimo e valuazione di μS:
tan(θM) = μS
(con θM angolo massimo in cui c'è ancora attrito statico).
- Forza di resistenza dell'aria:
- per ora solo considerazioni qualitative (assunte ben note);
- come introduzione alla fenomenologia si vedano link in Galleria.
- E, ancora a proposito di pesate, Archimete e Terzo Principio:
" 'pesa' più un palloncino sgonfio o uno gonfio?": → Galleria.
Problemi proposti
[Nota: corretto un refuso nella traccia del problema nr. 4 della lezione 6]- Sulle misure (simulate) degli aumenti delle letture della bilancia
in funzione
dell'affondamento di vari solidi (vedi Galleria):
→ valutare V(x), volume affondato in funzione dell'affondamento x, e quindi Δm(x),
massa dell'acqua spostata in funzione dell'affondamento, per- cilindro di raggio R;
- prisma, avente 'altezza' h (lato che nell'affondamento è ortogonale
alla superficie
dell'acqua), base L (lato ortogonale al precedente) e spessore d; - cono di altezza h e raggio di base R.
→ ricavarsi α e β nei tre casi in funzione dei parametri geometrici di ciascun solido. - Si immaginino tre oggetti aventi forma di parallelepipedo e stessa massa m
i quali formano una specie di trenino posto su un piano orizzontale privo di attrito.
Essi sono uniti uno all'altro attraverso un filo 'inestensibile e senza peso'.
Al primo 'vagoncino' (quello più a destra, per fissare le idee) è
applicata una forza esterna Fext che tende a trascinare il 'trenino'.
Si calcolino le espressioni- dell'accelerazione comune con cui si muove il trenino;
- della tensione fra il primo e il secondo vagoncino e di quella fra il secondo e il terzo.
- Si ripeta il problema precedente con la variante che in cui
fra vagoncini e piano orizzontale ci sia un attrito dinamico avente coefficiente μD=0.05. - Un oggetto, a riposo su un piano orizzontale, è collegato mediante
un filo ideale che passa su una carrucola altrettanto ideale a un oggetto sospeso,
il quale è quindi soggetto alla forza peso e alla tensione del filo.- Sapendo che la massa dell'oggetto posto sul piano vale 200 g e che
il coefficiente di attrito statico vale 0.4,
si valuti il valore massimo della massa sospesa affinché il sistema rimanga immobile. - Si valuti anche, in tale situazione di equilibrio, la tensione del filo che collega i due oggetti.
- Sapendo che la massa dell'oggetto posto sul piano vale 200 g e che
il coefficiente di attrito statico vale 0.4,
- Con riferimento alla foto eseguita in aula
e assumendo che essa mostri
la massima inclinazione del coperchio del laptop prima che il cancellino cominci a scivolare,
si valuti, seppur approssimativamente, il coefficiente di attrito statico fra cancellino e coperchio.
(Riportare anche i dati utilizzati, ricavati 'alla meglio' dalla foto.)
- Questioni sui problemi in corso.
- Lezione 8 (18/03)
-
- Delucitazioni sui problemi in corso e sugli ultimi argomenti trattati
passando in rassegna la Galleria - Dimensioni angolari e velocità angolare (dipendono dal 'punto di vista')
→ caso della ISS allo zenit
→ quanto tempo impiega la ISS ad attraversare lungo il diametro la luna? - Dai satelliti geostazioni a questioni legate a
- Problemi di gittata (seguito lezione 4).
- Esperimento in aula del lancio orizzontale di una moneta.
- Moto orizzontale con sola resistenza del mezzo
modellizzata con F = -β v.
("all models are wrong, ...")) - Equazioni 'ordinarie' e equazioni differenziali, incontrate
- nel problema del pozzo per il centro della Terra;
- nel problema di sola forza F = -β v su un corpo in moto
- Risoluzione mediante la tecnica di 'separazione di variabili'
[per ora per il solo caso dv/dt = -(β/m) v ] - Molla: introduzione pratica e teoria sottostante:
→ si arriva alla stessa equazione differenziale del problema dell'ipotetico pozzo per il centro della Terra. - Oscillatore armonico e significato di ω:
- pulsazione
- essa non va confusa con 'velocità angolare' se non c'è niente che ruota
o un angolo che varia in funzione del tempo (→ pendolo).
Problemi proposti
- Proseguimento del problema nr. 1 della Lezione nr. 6
(e con l'ausilio di quanto ottenuto nel successivo problema nr. 3).- Si calcoli la velocità angolare della ISS rispetto a un osservatore
posto sulla superficie terrestre quanto essa gli passa esattamente allo zenit
(da non confondere con la velocità angolare dell'orbita circolare da essa compiuta intorno alla Terra!).
- Si calcoli la velocità angolare della ISS rispetto a un osservatore
- Sul problema nr. 4 della Lezione nr. 3, il quale conteneva
palesi errori di battitura
(con velocità iniziale nulla in entrambe le coordinate i quesiti non avevano senso):- Rivedere la soluzione alla luce della formulazione corretta.
- Riscrivere la soluzione facendo uso del modulo del vettore ('v')
e dell'angolo che esso forma rispetto al piano orizzontale; - In particolare, avendo x(t=tG) il significato di
gittata e facendo uso
della 'ben nota' formula di duplicazione 'sin(2θ) = ... '
- riscrivere la formula della gittata in funzione di v e di sin(2θ);
- trovare per quale angolo si ha la gittata massima.
- Sull'esperimento in aula dei lanci della moneta:
per ciascun lancio ricavarsi:- il tempo 'di volo' (da quando si stacca dal tavolo a quando tocca il pavimento);
- la velocità di impatto (componenti e modulo);
- angolo di impatto;
- la distanza fra il punto in cui la moneta lascia il tavolo
a quello in cui tocca il pavimento
(essa ci dà una stima per difetto della lunghezza della traiettoria).
- Abbiamo visto a lezione il caso di una forza costante ('mg' nell'esempio specifico)
contrastata da una forza di 'viscosità -βv. La forza si annulla per vL=mg/β (→ 'velocità limite').
Estendiamo il ragionamento a una forza 'attiva' costante 'FA',
avendo quindi F = FA - βv.
In questo caso, più generale del precedente, l'espressione della velocità limite diventa vL=FA/β.- Dimostrare che, applicando il secondo principio e riscrivendo opportunamente
i vari termini, arriviamo alla seguente equazione differenziale

- Dire com'è il segno di dv/dt nei casi
- v > vL ;
- v = vL ;
- v < vL ,
- In analogia a quanto fatto a lezione nel caso di dv/dt = -v/τ
- risolvere l'equazione differenziale usando la tecnica
di separazione di variabili,
usando come condizione iniziale v(t=0)=v0, - controllando che, effettivamente, la soluzione dà v(t=0)=v0 e v(t→∞)=vL.
- risolvere l'equazione differenziale usando la tecnica
di separazione di variabili,
- Dimostrare che, applicando il secondo principio e riscrivendo opportunamente
- Abbiamo visto a lezione le oscillazioni di una molla quando
ad essa erano sospesi 3 dischetti di piombo.
→ Dire, giustificando l'affermazione, come varia il periodo di oscillazione quando il numero di dischetti è raddoppiato.
[Ovviamente stiamo ignorando la massa della molla stessa e del 'gancio',
così come stiamo trascurando la resistenza dell'aria e attriti interni alla molla, per la serie "all models are wrong, ..."]
- Delucitazioni sui problemi in corso e sugli ultimi argomenti trattati
- Lezione 9 (19/03)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso:
- Problema nr. 2, Lezione 7: non era stato scritto che il piano era privo di attrito.
- Problema nr. 3, Lezione 7: il valore numerico di μD
era troppo elevato, dati
i valori di m e Fext, per poter permettere il movimento del trenino: → diminuito.
- Media spettacolari:
'verosimili' o bufale?
('verosimile' ↔ 'vero' !). - Pendolo semplice (vedi animazione)
in approssimazione di:
- punto materiale sospeso;
- filo inestensibile e senza peso;
- assenza di resistenza dell'aria (ma un pendolo normale prima o poi si ferma...);
- piccole oscillazioni (θ << 1).
- Introduzione alla termologia:
↠ Vecchia Dispensa ('VD', lezioni.pdf): par. 14.6
↠ Galleria- Temperatura e quantità di calore;
- sistema isolato;
- principio zero della termodinamica;
- capacità termica e calore specifico;
- caloria e chilocaloria.
- Scambio termico fra corpi che formano (approssimativamente!) un sistema isolato
(VD, par. 14.7):
- temperatura di equilibrio;
- ruolo del recipiente → 'equivalente in acqua' del recipiente.
sia concettuale che matematica. - Digressione su questioni di storia della metrologia
- Unità romane;
- lunghezza: in particolare piede, passo, miglio
- massa ('peso'): libbra: 1/80 di piede cubo di acqua ('dolce').
- Origini del 'metro': cenni (fuori programma), in particolare:
- dal metro del secondo (vedi problema nr. 3) al metro del meridiano
(chi è interessato ad approfondire può vedere qui,
in particolare l'articolo su La grande cordata).
- dal metro del secondo (vedi problema nr. 3) al metro del meridiano
- Ruolo dell'acqua nelle unità attuali :
- caloria (ottenuta definendo unitario il calore specifico dell'acqua); :
- chilogrammo (non è un caso che un litro di acqua dolce è praticamente 1 kg, e 1 cm3 praticamente un grammo!).
- Unità romane;
Problemi proposti
- Si hanno 20 litri di acqua a 70 gradi. Quanta acqua fredda
(10 gradi)
bisogna aggiungere per ottenere una temperatura di equilibrio di 35 gradi?
(Si assuma che non ci siano dispersioni di calore verso l'ambiente
e che il contributo dei contenitori allo scambio termico sia trascurabile.) - Un cilindro di 200 g di alluminio (calore specifico circa 1/5 di quello
dell'acqua)
avente una temperatura di 90 °C immerso in un recipiente contenente mezzo litro di acqua a 10 °C.
Si trovi la temperatura di equilibrio (stesse assunzioni idealizzate del problema precedente). - Calcolare la lunghezza di un pendolo semplice che 'batte il secondo'
(ovvero ha un periodo di oscillazione di 2 s) in una località
dove il campo gravitazionale vale esattamente 9.80 N/kg. - Quanto può variare il valore calcolato nel problema precedente
se in diversi punti
della superficie terrestre g può variare al più di circa ±0.1%? - Calcolare le espressioni di
- velocità angolare di un pendolo (da non confondere con la pulsazione 'ω'!) in funzione del tempo;
- velocità lungo l'arco di circonferenza percorso dal punto materiale.
[Si consideri la soluzione particolare 'standard' in cui il pendolo a t=0
ha l'angolo massimo rispetto alla verticale e ha velocità nulla.] - Un oggetto (modellizzato come 'punto materiale')
di 100 g è sospeso a un filo 'ideale' di 1 m.
- Si calcoli la tensione del filo quando l'oggetto penzola a riposo verticalmente.
- Successivamente il 'pendolo' viene fatto oscillare con un angolo
massimo di 5°.
Si calcolino, nell'istate in cui l'oggetto transita per θ=0;- la sua velocità;
- la sua accelerazione centripeta;
- la forza centripeta che agisce su di esso;
- la tensione del filo e la si confronti con quanto ottenuto nel caso stazionario.
→ prima arrivare alle 'formule risolutrici' e poi inserire i valori numerici dei parametri del problema.]
- Chiarimenti sui problemi in corso:
- Lezione 10 (21/03)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso:
- problema nr. 2, Lezione 9;
- problema nr. 5, Lezione 9.
- Epitaffio di Stevino (→ Galleria)
- Analisi degli affondamenti:
- calcolati V(x) per cilindro, prisma e cono?
- analisi empirica dei dati dei cilindri
(→ Galleria)
- retta a occhio che 'dà retta' un po' a tutti i punti.
- parametri della retta per due punti (in questo caso si impone il passaggio per l'origine);
- ricavare i parametri geometrici (o loro relazione) dalla 'pendenza della' retta.
- Linearizzazione di andamenti di potenza:
- ipotizzare l'andamento ed effettuare un cambiamento
di variabili:
→ Galleria per quanto riguarda la Terza Legge di Keplero. - uso di scale logaritmiche ('log-log', o 'doppio-log')
e carte logaritmiche
Dettagli in Le basi del metodo sperimentale, par. 6.7.4,(*) pp. 105-106, con qualche osservazione- I passaggi importanti sono
- Eq. (6.27), che definisce l'andamento, prontamente linearizzato nella (6.28);
- α rappresenta quindi la pendenza (slope)
dell'andamento linearizzato e
si ricava dal rapporto incrementale della (6.31),
possibilmente riscritto come il rapporto dei log di y2/y1 e di x2/x1
(questa scrittura elimina il problema delle unità di misura,
in quanto gli argomenti dei logaritmi devono essere adimensionali,
di cui si disquisisce a cavallo fra pp. 105 e 106). - Infine, una volta trovato α, si applica
la (6.27) a uno qualsiasi dei punti sulla retta
e,
invertendo la relazione, si arriva alla (6.33) per β [per capirsi, la (6.32) è una inutile complicazione].
si vedano i precedenti paragrafi 6.7.2 e 6.7.3] - I passaggi importanti sono
- Si noti come le scale logaritmiche sono usate anche quando si vogliono
riportare in uno stesso plot grandezze fisiche i cui valori si estendono
su più ordini di grandezza, come nell'esempio riportato in Fig. 6.9 a pag. 107 della stessa dispensa.
- ipotizzare l'andamento ed effettuare un cambiamento
di variabili:
Problemi proposti
- Sull'epitaffio
di Stevino:
assumendo che la 'catena' abbia densità di massa lineare costante
dimostrare che le forze sui due piani inclinati si bilanciano esattamente. - Analisi degli affondamenti dei due cilindri
(vedi Galleria)
- riprodurre in qualche modo la figura
mostrata a lezione
tracciando le due rette passanti per l'origine e che passino 'al meglio' fra i punti sperimentali; - ricavarsi i coefficienti di linearità m1 e m2 per i due cilindri;
- da m1 e m2 ricavarsi i diametri dei due cilindri.
- riprodurre in qualche modo la figura
mostrata a lezione
- Analisi dell'affondamento di prisma e cono
(i caso dei cilindri è da riterersi facile):
- linearizzare i dati di affondamento mediante opportuna trasformazione
della variabile che quantifica l'affondamento; - ricavarsi empiricamente, mediante opportuna retta che passa fra i dati,
i coefficienti degli andamenti linearizzati; - dai coefficienti ottenuti:
- ricavarsi, nel caso del cono, il rapporto fra raggio di base e altezza;
- dal valore ottenuto nel punto precedente ricavarsi l'angolo
si 'semiapertura' del cono, ovvero fra l'asse e la superficie; - ricavarsi, nel caso del prisma, il rapporto fra base e altezza,
nell'ipotesi che lo spessore valga 2.1 cm; - dal valore ottenuto nel punto precedente ricavarsi l'angolo
al vertice del prisma.
- linearizzare i dati di affondamento mediante opportuna trasformazione
- Dati i seguenti dati (non affetti da fluttuazioni dovute a errori sperimentali):
x: 0.10 0.25 0.63 1.58 3.98 10.00
y1: 6.32 3.99 2.52 1.59 1.00 0.63
y2: 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.58
y3: 0.63 1.00 1.59 2.52 3.99 6.32
y4: 10.00 3.98 1.58 0.63 0.25 0.10
graficare i punti su carta logaritmica ('log-log') e ricavarsi i parametri 'a' e 'b'
delle quattro leggi di potenza yi = ai · xbi da cui essi derivano.
(Si raccomanda di usare la carta millimetrata distribuita a lezione
anche se può essere un utile esercizio fare i plot, ed eventualmete
anche il resto dell'analisi, anche al computer.)
- Chiarimenti sui problemi in corso:
- Lezione 11 (25/03)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- ...
- Continuazione del problema della ninfea: → sotto.
- Potenza di una sorgente di calore: cal/s; kcal/h, etc.
- Ancora Termologia:
- Cambiamenti di stato (VD, par. 16.1):
- calore latente ('di fusione', 'di evaporazione');
- calore latente specifico ('λ').
- Velocità di termalizzazione T(t) [VD, par. 16.2]
- A proposito del problema nr. 4 della Lezione 8:
→ soluzione mediante cambiamento di variabili, in analogia a quanto fatto nel par. 16.2.2 VD.
- Cambiamenti di stato (VD, par. 16.1):
- Pressione
(→ dispensa_pressione.pdf —
solo quanto visto a lezione o indicato qui nel seguito)
- Concetti di base (da pressione media a pressione locale).
- Unità di misura nel SI: decisamente poco antropica.
- Pressione nei fluidi: ricordare che la pressione è uno scalare.
- Parentesi: campi scalari e campi vettoriali
- www.ilmeteo.net/ (
animazione particelle; isobare)- le pressioni sono date dal colore;
- le isobare collegano i punti la stessa pressione (opportunamente discretizzata).
- it.windfinder.com:
- le frecce danno i versori;
- le intensità sono date dal colore.
all'esterno della Terra dovuto alla Terra stessa (e, in analogia, vedremo
il campo elettrico dovuto a una particella carica.)]
- www.ilmeteo.net/ (
- Legge di Stevino e 'principio' (storicamente) di Archimede
- Principio dei vasi comunicanti
(a cosa è dovuta la pressione all'interno dell'aula Aula 4?) - Principio di Pascal per fluidi incompressibili
[Refuso due linee sotto la (2.181):col il volume→ "con la profondità"] - Condizione di galleggiamento (semplice 'esercizio' lasciato a lettura individuale).
- Dall'horror vacui alla 'rivoluzione torricelliana'
- Macchine per il vuoto e emisferi di Magdeburgo
Problemi proposti
- Sul problema nr. 15 del test di autovalutazione:
è 'pacifico' che per t=190h
l'ipotetica ninfea occupa S/2, con S la superficie dello stagno, ovvero A(t=190h)=S/2;
così pure che A(t=180h)=S/4 e A(t=170h)=S/8, e così via, di 10 ore in 10 ore.
La cosa più interessante è cosa succede a tempi intermedi:- scrivere l'espressione di A(t), in unità di S, valida con continuità da 170 e 200 ore;
- verificare che per 170, 180, 190 e 200 ore si riottengono i valori che sappiamo;
- calcolare quanto vale A(t), sempre in unità di S, per t=175h, t=185h e t=195 h.
- Sulla legge di termalizzazione: trovare l'espressione,
in funzione della costante di tempo τ,
del tempo di dimezzamento 't1/2', ovvero del tempo necessario affinché la differenza
di temperatura del corpo rispetto a quella asintotica ('TF') si dimezzi. - Continuazione del problema nr. 2 Lezione 9:
immaginiamo che acqua e alluminio raggiungano una temperatura di equilibrio
di mezzo grado inferiore a quella che ci saremmo aspettati dai dati del problema.
→ Calcolare la capacità termica del recipiente in cui è racchiusa l'acqua;
→ dire a quanti grammi di acqua equivale. - Un corpo, inizialmente a 20 °C viene immerso in un grande contenitore ('A')
contenente acqua a 50 °C. Successivamente, dopo che si è termalizzato,
esso viene tolto dall'acqua calda e immerso in un altresì grande recipiente ('B') di acqua a 10°.
Assumendo che la costante di tempo ('τ') del processo di termalizzazione
valga in entrambi i casi 60 s,- si scrivano le espressioni T(t) in entrambi i casi, ponendo t=0
nell'istante in cui il corpo è immerso in ciascuno dei recipienti; - si valuti dopo quanto tempo dall'immersione esso
raggiunge la temperatura di 30 °C
- quando è immerso nel recipiente A;
- quando è immerso nel recipiente B.
- si scrivano le espressioni T(t) in entrambi i casi, ponendo t=0
- Un cilindro di superficie di base 2 cm2 e altezza 5 cm è composto
di un materiale avente una densità di 0.85 g/ cm3 non solubile in acqua (e tanto meno si impregna)
Il cilindro è indrodotto in un bicchiere d'acqua e, come è ben noto, esso non affonda completamente.
Sapendo che il bicchiere con l'acqua è posto su una bilancia e che inizialmente
il display indicava un certo valore in grammi,
→ dire se ed eventualmente di quanto varia il valore indicato
dal display dopo che nel bicchiere è stato introdotto il cilindro.
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 12 (26/03)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Problema del curioso tacchino.
- Densità di uovo di polistirolo (dettagli fuori programma)
- Tubo a U:
- suo uso come manometro (differenziale, 'ovvero non assoluto');
- analisi delle oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio
→ ancora oscillazioni armoniche (trascurando l'inevitabile attrito)
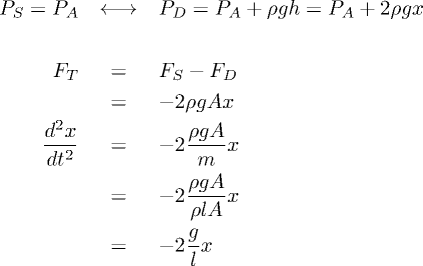
→ cosa ci ricorda?
- A proposito della 'Vecchia Dispensa'
(Ripassi, approfondimenti e nuovi temi)(*)
- par. 2.1-2.4, pp. 3-5 (moto rettilineo con velocità uniforme o accelerazione variabili)
- par. 5.2-5.3, pp. 10-12 (moto circolare uniforme)
- par. 5.4, p. 12 (oscillazione armonica)
- par. 5.5, p. 13 (seconda legge di Newton)
- par. 6.2, p. 14 (dimensioni e unità di misura: come riferimento e non da tentare di imparare a memoria!)
- par. 6.3-6.6, pp. 16-18 (esempi di forze e azione-reazione)
- par. 6.7, pp. 20-21 (corpo sospeso a corda)
- par. 7.2, pp. 22-23 (analisi della molla, con dati sperimentali di allungamento e periodo)
- par. 7.3, pp. 24-25 (pozzo per il centro della Terra);
- par. 7.4, pp. 25-26 (attrito statico e attrito dinamico)
- par. 7.5.1, pp. 26-28 (problema con forza peso, filo e carrucola)
- par. 7.5.2, pp. 28-29 (problema precedente + forze di atttrito)
- par. 8.2.1, pp. 30-31 (velocità massima in curva)
- par. 8.2.2, pp. 31-32 (terza legge di Keplero)
- par. 8.3, pp. 32-33 (piano inclinato, con e senza attrito)
- par. 8.5, p. 34 (pendolo semplice)
- par. 8.5, pp. 34-36 (equazioni differenziali che danno luogo a oscillazioni armoniche)
- par. 9.1, p. 38 (satelliti)
- par. 9.3, pp. 38-39 (uso di integrali in cinematica)
- par. 9.4-9.8, p. 40-45, a partire dal problema del cannoncino
- introduzione de facto alla quantità di moto e alla sua conservazione;
- impulso della forza e consequente variazione della quantita di moto;
- terzo principio e conservazione della quantità di moto;
- centro di massa di un sistema;
- effetto di forze esterne su un sistema di punti materiali.
- par. 14.4-14.7, pp. 71-75 (introduzione alla termologia)
- par. 16.1, pp. 81-82 (calore latente)
- par. 16.2, pp. 82-83 (velocità di termalizzazione — segue a par. 19.6, p. 103)
- par. 19.5, p. 103 (caduta in campo gravitazionale, con resistenza del mezzo
modellizzata come -βv) - par. 19.7, pp. 104-105 (soluzione per 'separazione di variabili'
dell'equazione differenziale che dà luogo a leggi esponenziali)
Non è necessario né consigliato mettersi a risolverli sistematicamente tutti,
ma può essere una buona idea leggere i quesiti e farsi un'idea se si sarebbe
in grado di risolverli, eventualmente con l'ausilio del formulario del corso.]
- A proposito di impulso della forza e variazione della quantita di moto:
→ riscriviamola insieme a una uguaglianza che già conoscevamo (vedi es. Lezione 3):

→ ??? (pensarci su...)
Extra
codice Python per analizzare altri dati di affondamenti
(grazie a Francesco Safai Tehrani):- dati: misure_affondamenti.dat (interessanti perché contengono anche valori 'NA')
- affondamenti_overview.py
- analisi_affondamenti.py
→ provare ad usare per analizzare i 'nostri' dati (simulati → Galleria).
Problemi proposti
- Un curioso ipotetico animale della mitologia matematica → file pdf, problema nr.1 Lezione 12.
- Altro simpatico quesito, da provare a risolvere in vari modi
(la soluzione migliore è quella che richiede meno conti...):
→ 'Vecchia Dispensa', nr. 1 a pag 9. - Problema nr. 2 pag. 29 'Vecchia Dispensa'.
- Un ipotetico eso-pianeta compie un'orbita circolare intorno
al suo 'Sole'.
Sapendo- che la sua distanza dal suo Sole è pari a quella nostra dal nostro Sole;
- la sua velocità di rivoluzione è pari al doppio della nostra,
- Un oggetto ('punto materiale') di massa m1=100 g che
viaggia su un piano orizzontale
privo di attrito alla velocità di 10 m/s ne urta un altro di massa m2 che stava fermo.
Dopo l'urto i due corpi rimangono attaccatti e procedono (senza attrito!)
lungo la direzione e il verso del corpo urtante.
Si valuti la loro velocità nei seguenti casi:- m2 = m1;
- m2 = 2 m1;
- m2 = m1/2;
- m2/m1 → 0;
- m2/m1 → ∞.
prima dell'urto e confrontarla con quella dopo l'urto. - Sull'immagine del tubo a U in
Galleria:
→ ricavarsi la 'sovrappressione' (rispetto a quella atmosferica) all'interno del palloncino
→ nell'ipotesi che il lato di ciascuna mattonella della parete sia 15 cm
→ e il diametro interno del tubo 1.5cm.
Siamo esattamente a 1/3 del corso - Lezione 13 (4/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Problema del cagnolino: vedi → problema nr. 1.
- L'interesse di tale problema è legato alle varianti a cui si presta.
- Il quesito 1 del problema è legato ai veri 'classici'
quesiti di cinematica su incontri/sorpassi
fra 'punti materiali':
→ si raccomanda di cominciare, come abbiamo fatto a lezione, disegnando i vari diagrammi orari
dei vari 'punti materiali' in moto su percorsi 'rettificati': un treno che "va da Roma a Milano a 100 km/h"
non segue una traiettoria rettilinea (né tantomeno parte di colpo dalla Stazione Termini a 100 km/h
e arriva a tale velocità dentro la Stazione Centrale — all models are wrong, ...).
- Problema del tacchino esponenziale (e della ninfea) (vedi sotto 'Leggi esponenziali').
ma le soluzioni richieste devono essere consistenti con le ipotesi dichiarate nel quesito.] - Problema del cagnolino: vedi → problema nr. 1.
- Problema della misura della profondità del pozzo
usando il rumore del tonfo
(vedi sotto → problema nr. 2):- L'interesse di tale problema è legata alle varianti a cui si presta.
- Leggi esponenziali (a partire da progressioni geometriche)
→ per i dettagli vedi qui.
- Peso dell'aria
- Esperimento in aula riempiendo di aria due bottiglie inizialmente 'vuote';
- Volume delle bottiglie: da ricavare
dall'aumento di peso se riempite d'acqua (di rubinetto),
rispettivamente 777.6 g e 969.6 g. - Peso dell'aria nei due casi:
- Pesata bottiglia da 3/4 (nominali)
- Bottiglia grande Δm = 1.14 g.
[Nota: siccome la sola bottiglia pesava più dei 500g della portata della bilancetta
abbiamo usato il trucco di accendere la bilancia quando la bottiglia vi era già posizionata sopra
in modo che lo zero iniziale della bilancia la includesse.]
- Equazione di stato dei gas perfetti
- Formula alla lavagna:
— per il valore numerico di R 'arrangiarsi' (attenzione alla unità di misure raccomandate). - Definizione moderna di mole: →
https://it.wikipedia.org/wiki/Mole
- Nota sul fatto che testi non recentissimi possono riportare definizioni 'storiche'.
- Analogia fra il valore esatto di mole e il valore
esatto della velocità della luce
(la voce della versione italiana è ambigua).
[Sono seguiti ulteriori chiarimenti sulla storia del metro, di cui si era già fatto cenno.
In particolare, attualmente esso è definito attualmente dal secondo e dalla velocità della luce. ]
- Ancora sulla pressione nei gas (concetto, come abbiamo visto, non intuitivo),
con cenni (qualitativi) alla teoria cinetica dei gas basati sull'analisi di "P ∝ n T / V".
- Formula alla lavagna:
- Uso della carta 'semilog' (scala verticale deformata logaritmicamente)
→ Le basi del metodo sperimentale, par. 6.7.2 e 6.7.3
Problemi proposti
- Sul problema del cagnolino (soprattutto per chi è
arrivato correttamente alla soluzione
senza passare per i dettagli indicati nel seguito), indicando con d0
la distanza iniziale del padrone, v la sua velocità e αv quella del cagnolino.- Per il primo andirivieni del cagnolino,
- valutare l'espressione dell'istante t1 in cui si incontrano la prima volta;
- la distanza (x1) dalla casa in cui si incontrano la prima volta;
- lo spazio (s1) per corso dal cagnolino nella sua prima andata e ritorno dalla casa.
- Estensione ai primi 10 andirivieni (ovviamente assumendo il cagnolino 'puntiforme', etc):
- estendere quando ottenuto nel punto precedente per
ottenere l'espressione dello spazio percorso in n andirivieni - usando Python, R o altro, valutarsi il percorso totale in funzione
di n, usando i seguenti dati numerici:
d0 = 100m, v = 5 km/h, α = 4.
- estendere quando ottenuto nel punto precedente per
- Facendosi aiutare da Wolfram Alpha o da ChatGPT ricavarsi l'espressione
del percorso totale in funzione di d0, v e α (ovviamente il problema ha senso per α ≥ 1).
- Per il primo andirivieni del cagnolino,
- Profondità del pozzo lanciando un oggetto e sentendo il rumore del tonfo
(tempo fra rilascio e arrivo suono: 3 secondi; velocità del suono 340 m/s).- Soluzione di 'ordine zero' (sempre importante!) assumendo infinita la velocità del suono.
- Soluzione ottenuta risolvendo l'equazione di secondo grado.
- Di quale problema è soluzione la soluzione spuria?
- Soluzione iterativa mediante Python o altro:
- partire dalla profondità valutata in approssimazione di vs infinita;
- sottrarre al tempo misurato il tempo impiegato dal suono per percorrere tale distanza;
- rivalutare la profondità dal tempo ottenuto;
- iterare il ragionamento un 'certo numero di volte' e riportare i risultati in una tabella (ordine 0, ordine 1, etc.).
- Valutare quanto dista dal centro della Terra il centro
di massa Terra-Luna: riportare il risultato in unità di RT.
(Prima di fare i conti si raccomanda di esprimere la massa della Luna in unità
di masse della Terra e la distanza Terra-Luna in unità di raggi terrestri.) - Dai dati delle pesate (vedi sopra) ricavarsi, per le due bottiglie,
il rapporto fra la densità
dell'aria e la densità dell'acqua, prestando attenzione alla cifre significative.
[Nota: ovviamente i due valori dovrebbero essere identici, ma essi possono differire a causa di diversi effetti di natura sperimentale.] - Dai dati del pesate delle bottiglie prima 'vuote' o poi piene di aria e assumendo,
al fine di usare tutti gli stessi dati, P = 1025 hPa e T=22 °C,- valutare il numero di moli e quindi il numero molecole di aria contenuti nelle due bottiglie;
- valutare il rapporto fra la densità dell'aria e la densità dell'acqua;
- valutare la massa media di una 'molecola di aria'.
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 14 (8/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso:
- richieste di chiarimenti
(discussi nella lezione odierna i primi quattro punti della lista); - altri chiarimenti (in particolare l'epitaffio di Stevino)
- richieste di chiarimenti
- Calcolo dimensionale:
spesso in Fisica le grandezze fisiche, incluse le 'costanti fisiche' (ad es. G),
sono legate da espressioni monomie, ovvero del tipo Y = f · Πi Xiαi, con 'f' un fattore numerico.
- Abbiamo già visto l'importanza dei controlli dimensionali.
- La cosa simpatica — e potente! — è che è anche possibile
ricavarsi
le potenze αi da pure considerazioni dimensionali.- Ad esempio in una 'caduta libera' la distanza s può solo dipendere da g e t.
→ s ∝ gα1 · tα2 ↠ trovare α1 e α2.
(Con le solite idealizzazioni di rito).
[Commenti sui modelli: → lezione scorsa] - E se ci mettiamo anche la possibile dipendenza dalla massa?
- Ad esempio in una 'caduta libera' la distanza s può solo dipendere da g e t.
- Un curioso integrale (analogo a quello visto in una
lezione precedente):
— questa volta invece di integrare ax in 'dt' la si integra in 'dx';
— idem per le altre componenti;
— sommando i tre integrali si arriva a un 'curioso risultato'.
—Ma per capirlo bene occorre definire il... - Prodotto scalare fra vettori:
- Richiami su vettori e versori nel piano e nello spazio
(e versori 'di base' lungo gli assi cartesiani). - 'Vecchia Dispensa', par. 10.4.
- Esempi 'live' in Galleria
- Richiami su vettori e versori nel piano e nello spazio
- 'Lavoro' e variazione di 'energia cinetica'
(per ora mere definizioni formali)
→ 'Vecchia Dispensa', par. 9.9.
Problemi proposti
- Dati i due vettori a = (1, -2, 3) e b = (0, 1, 1), trovare
- i loro moduli;
- i versori corrispondenti;
- la loro somma;
- il loro prodotto scalare;
- l'angolo fra essi compreso.
- Ricavarsi, mediante calcolo dimensionale
e a meno di una costante di proporzionalità
numerica,
il periodo di oscillazione di un pendolo di lunghezza l e massa sospesa m in campo gravitazionale g.
- Ricavarsi, mediante calcolo dimensionale e a meno di una costante di proporzionalità
numerica,
la dipendenza dello spazio di frenata dalla 'decelerazione' di modulo |a| e dalla velocità iniziale v0. - Calcolare l'espressione del lavoro nei seguenti casi unidimensionali:
- F(x) = -m·g [limiti: a) da x=h a x=0; b) da x=0 a x=h);
- F(x) = -k·x [limiti: da x=x0 a x=0];
- F(x) = -k·x [limiti: da x=0 a x=x0];
- F(r) = - (g/RT) r [limiti: da r = RT a r=0];
- F(r) = - m·g·RT2/r2 [limiti: da r=R a r→∞ (con R ≥ RT) ];
- F(r) = - m·g·RT2/r2 [limiti: da r→∞ a r=R (con R ≥ RT) ];
- FA = -μD·m·g· v/v [a) da x1 a x2; b) da x2 a x1]. [Nota: 'v' sta, come in molti libri di testo, per il vettore velocità, mentre 'v' per il suo modulo.)]
- Chiarimenti sui problemi in corso:
- Lezione 15 (9/04)
-
- Eclisse di Sole di ieri. Dati importanti:
- Diametro angolare Sole: 31.94' (range: 31.6'-32.7')
- Diametro angolare Luna: 33.12' (range: 29.43'-33.5')
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lavoro e variazione di energia cinetica
- Per cominciare (casi unidimensionali) sembra solo un 'trucco' per
- calcolare variazioni di velocità
senza passare per i dettagli della cinematica:
→ Esempio nr. 1 par. 10.2 'Vecchia Dispensa'; - risolvere problemi dinamici nei quali la forza
provoca una variazione di velocità:
→ Esempii nr. 2 e 3 par. 10.2 'Vecchia Dispensa'.
- calcolare variazioni di velocità
senza passare per i dettagli della cinematica:
- In alcuni casi (importanti)
il lavoro totale andando 'avanti indietro' è nullo:
→ la velocità nello stesso punto riacquista lo stesso valore;
→ l'energia cinetica scompare e riappare:
→ → forze conservative.
- Per cominciare (casi unidimensionali) sembra solo un 'trucco' per
- Casi i cui entra in gioco il prodotto scalare (e forze conservative):
- capiamo come mai in un moto circolare uniforme la forza non
cambia il modulo della velocità
(ma la velocità cambia!) - riusciamo a risolvere problemi per i quali i calcoli dei
dettagli cinematici
diventalo difficili, se non addirittura impossibili (almeno la soluzione analitica):
→ piano inclinato vs guide arcuate in Galleria;
→ 'giro della morte' in Galleria; - si capiscono quantitativamente piani inclinati, leve e carrucole:
→ esempi in Galleria;
- capiamo come mai in un moto circolare uniforme la forza non
cambia il modulo della velocità
Problemi proposti
- Dati i seguenti dati
(non affetti da fluttuazioni dovute a errori sperimentali)
x: -5.00 -2.00 1.00 4.00 7.00 10.00
y1: 50.00 16.57 5.49 1.82 0.60 0.20
y2: 0.50 1.05 2.19 4.57 9.56 20.00
y3: 0.10 0.21 0.44 0.91 1.91 4.00
y4: 5.00 2.85 1.62 0.92 0.53 0.30
graficare i punti su carta logaritmica ('semilog') e ricavarsi i parametri 'a' e 'α'
delle quattro leggi esponenziali yi = ai · eαi·x da cui essi derivano.
(Si raccomanda di usare la carta millimetrata distribuita a lezione
anche se può essere un utile esercizio fare i plot, ed eventualmete
anche il resto dell'analisi, anche al computer.) - Un punto materiale di massa 1 kg parte dall'altezza di 1 m e scivola lungo
un piano inclinato
privo di attrito e lungo sqrt(2) m (vedi Galleria).- Calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso.
- Calcolare la velocità finale 'vF' raggiunta, facendo uso del lavoro compiuto dalla forza peso.
- Ipotizziamo ora (con riferimento al problema precedente)
che fra il piano inclinato
e il punto materiale ci sia un atttrito dinamico di coefficiente μD incognito.
→ Si valuti μD dalla velocità raggiunta ('vFAD') e esprimendo il risultato
→ in funzione di r, definito come r= vFAD/vF, ovviamente minore di 1.
→ Si calcoli il valore numerico di μD nel caso di r=1/2. - Un pendolo semplice di lunghezza l=1m (e con le solite idealizzazioni)
è spostato
di θ0=20° dalla posizione di equilibrio e quindi lasciato oscillare.
Si calcolino- l'innalzamento del punto materiale dalla
sua quota minima
quando l'angolo del pendolo vale θ0; - usando i concetti di lavoro ed energia cinetica
si valuti la velocità
del punto materiale quando esso transita per θ=0; - si calcoli quindi la corrispondente velocità angolare.
- l'innalzamento del punto materiale dalla
sua quota minima
- Facendo uso di quando ottenuto in problemi riguardanti il
pendolo di lezioni precedenti,
si calcoli la velocità in θ=0 ottenuta facendo uso delle formule usate a suo tempo
e valide nell' approssimazione di piccoli angoli.
→ Si confronti il risultato con quanto ottenuto nel punto 4.2.
- Eclisse di Sole di ieri. Dati importanti:
- Lezione 16 (11/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Sulla proprietà distributiva del prodotto scalare:
semplice dimostrazione geometrica in 2D.
- Esperimento del pendolo interrotto di Galileo:
→ Galleria
- Esperimento del Mulinello di Joule, cruciale per capire come
l'energia cinetica 'definita ad hoc' nel punto precedente sia veramente energia:- Galleria
- Trasformazioni di energia: meccanica → termica.
- Energia potenziale
- l'energia cinetica può scomparire e poi ricomparire;
- forze conservative:
- forze per le quali il lavoro su un cammino chiuso è nullo;
- l'esempio più famoso è quello gravitazionale;
- ma anche la forza di Coulomb lo è (ovvio, avendo la stessa 'struttura' matematica!).
- Conservazione dell'energia
- Potenza
- Unità di misura di energia e potenza
- Riferimenti sulla
'Vecchia Dispensa':
- par 9.9;
- par 10.2-10.7;
- par 11.1-11.4;
- par 13.4;
- par 14.5;
- par 15.1-15.3, 15.5.
- Riepilogo concettuale:
- Seconda Legge di Newton:
dp/dt = F → dp = Fdt - Integrando da t1 a t2 e chiamando impulso
l'integrale di F in dt:
↠ l'impulso è causa della variazione di quantità di moto. - L'accelerazione varia la velocità e, in particolare,
- il prodotto scalare a·ds causa d(v2/2);
- il prodotto scalare m·ads causa d(m·v2/2);
- chiamando lavoro
(infinitesimo) m·a·ds
e energia cinetica la quantità m·v2/2
(e ottenendo il lavoro finito sommando gli infiniti elementi infinitesimi → integrale):
- Per certi tipi di forze ('conservative') la 'cosiddetta'
energia cinetica sparisce e poi ricompare:
↠ energia potenziale. - Altre volte invece
- il lavoro (che sappiamo che c'è!) non produce energia cinetica (visibile macroscopicamente!);
- l'energia cinetica (visibile macroscopicamente!) sparice.
↠ conservazione dell'energia - Possiamo anche fare il contrario, ovvero riottenere energia
cinetica 'visibile macroscopicamente'
e quindi la cosiddetta 'energia meccanica'?
→ non banale (→ termodinamica, fuori programma).
- Seconda Legge di Newton:
- Formulario del corso (importante controllare ogni tanto)
Ma cosa'è l'energia?
→ Concetto legato alla sua conservazione — Definizione in Wikipedia inglese (si stressa la sua proprietà di esser traferita senza scomparire)
— Definizione in Wikipedia italiana (legata alla "capacità di compiere lavoro":(*) → uhm... pessima)
— [idem su Treccani e libri di testi,(**) almeno per quanto riguarda la definizione]
— Un articolo abbasta recente sulla questione (più o meno ok)
— Interessante la voce di Wikipedia francese e la citazione di Max Plank riportata
— in fondo alla parte storica (e l'articolo richiamato nella nota 48 — sito visitato 10/04/2024):
— "Tratterò del concetto di energia solo nella misura in cui può essere attaccato al principio
— che dà il titolo a questo saggio, supponendo che il concetto di energia in fisica
— tragga il suo significato soprattutto dal principio di conservazione che la riguarda" [→ Feynman]
—(Das Prinzip der Erhaltung der Energie, 1887)
— Interessanti slides sul tema(*) Uhm... - In Fisica è la forza che 'compie lavoro'.
- Se un punto materiale ha una energia cinetica che 'lavoro compie'?
→ Eventualmente è la forza applicata su di essa a compiere lavoro e quindi
→ ad aumentarne o diminuirne l'energia cinetica, a seconda del segno del lavoro.
(**) Diciamo 'furbescamente', ma senza dire niente di errato.- Evita accuratamente di definire il termine 'energia' (come concetto generale).
- Parla invece direttamente, nel par 6.2,
di energia cinetica, affermando che essa
è una 'forma di energia' "associata al moto" e di cui l'auto è inizialmente in possesso,
e utilizzata nel seguito, nell'urto contro il muro, per deformarsi. - Quindi definisce nella (6.32)
l'energia cinetica di un punto materiale in moto,
e da quel punto diciamo che il gioco è 'facile'.
Problemi proposti
(VD: 'Vecchia Dispensa':)- VD, par. 10.8, nr. 4.(1)
(Domada intermedia: ricavarsi k della molla.) - VD, par. 10.8, nr. 5.(1)
- VD, par. 10.8, nr. 18, ove 'risultante' indica somma delle due forze.
- VD, par. 11.8, nr. 1.(2)
- VD, par. 11.8, nr. 2(2) (il lavoro richiesto va calcolato nel tratto di andata).
- VD, par. 13.6, nr. 2.(1)
Note:- Per velocità di fuga si intende la velocità che un
oggetto deve avere affinché,
lanciato verticalmente, arrivi a distanza 'infinita' (R → ∞) con velocità nulla.
(In pratica questo problema è una continuazione del nr. 4.5 della Lezione 14.) - Ovviamente si trascuri, come al solito, l'effetto dell'atmosfera.
- Nel caso della Terra si confronti quanto ottenuto (non solo il risultato numerico!)
con la velocità dell'altrettanto ipotetico satellite in orbita radente.
- Per velocità di fuga si intende la velocità che un
oggetto deve avere affinché,
- Uno scaldabagno ha una potenza di 1000 W.
→ Calcolare quanto impiega a scaldare 80 litri di acqua da 10 a 60 gradi. - Esperimento in aula per misurare la potenza necessaria
per sollevare un corpo di una certa quota in un certo tempo.
Per i dati: foto lavagna
(1) Far uso dei concetti introdotti questa settimana, senza i dettagli della cinematica;
(2) Vale nota (1) e, in particolare, usare il concetto di energia potenziale. - Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 17 (15/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Energia potenziale
- forza peso;
- molla;
- gravità per R > RT (da continuare).
- Introduzione a radiometria e fotometria

Problemi proposti
- [1-5] Problemi nr. 1-5 delle slides.
(Nota: problemi illustrati in aula). - [6] Assumendo che l'espressione dell'energia potenziale
di un oggetto di massa m
posto alla distanza R dal centro di un corpo celeste di massa M
sia data da Ep(R) = -G·M·m/R,
ricavarsi l'espressione della forza F(R).
(Nota: l'espressione risultante è ben nota, ma è importante ricavarsela.) - [7] Un punto materiale ha una energia potenziale che dipende
dalla coordinata x
secondo la seguente espressione:
Ep(r) = a·x2 + b·x,
con a = 10 J/cm2 e b = - 20 J/cm.- Trovare la forza che agisce sul punto materiale in funzione di x, ossia F(x).
- In particolare, calcolare per quale valore di x la forza si annulla.
- Lezione 18 (16/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Ancora su energia potenziale,
in particolare energia potenziale gravitazionale.
→ Vecchia Dispensa par. 13.4 (attenzione al refuso notato a lezione)
- Proseguimento introduzione alla fotometria:
→ slides
(Si raccomanda di vedere anche quanto riportato sul formulario.)
Problemi proposti
- Si immagini un corpo di massa m in orbita circolare
intorno alla Terra.
- Sapendo che la forza centripeta è dovuta
alla forza di gravità
si scriva l'espressione di m·v2 in funzione dei parametri orbitali... - ... e quindi si scriva l'espressione dell'energia cinetica in funzione di tali parametri.
- Si scriva quindi l'espressione dell'energia totale,
somma dell'energia cinetica
e dell'energia potenziale (per quest'ultima si usi lo convenzione usuale
di porre lo zero all'infinito).
- Sapendo che la forza centripeta è dovuta
alla forza di gravità
- Proseguimento del problema precedente:
- Si calcoli l'espressione dell'energia necessaria per portare tale corpo
dall'orbita
circolare di raggio R a un'orbita circolare di raggio 2R.
[Questo concetto è simile a quello della 'eccitazione', nel quale un elettrone passa da un 'livello' a un altro.] - Si calcoli l'espressione dell'energia necessaria per 'sottrarre' tale
corpo alla Terra
(ovvero di portarlo fino a distanza infinita a velocità nulla).
[Questo concetto è simile a quello della 'ionizzazione', nel quale si sottrare un elettrone a un atomo.]
- Si calcoli l'espressione dell'energia necessaria per portare tale corpo
dall'orbita
- Mediante un'app si misura l'illuminamento su una parete.
Esso vale 150 lx.
Successivamente si accende una torcia elettrica, posta a 5.0 m di distanza dalla parete
e puntata ad essa ortogonalmente. La torcia proietta sulla parete un disco di luce
'quasi omogeneo' di diametro 2.0 m. In queste condizioni l'illuminamento sale a 400 lx.
Si calcoli il flusso luminoso emesso dalla torcia (ovviamente stiamo trascurando
i possibili effetti di diffusione della luce della torcia nella stanza). - Sul problema precedente:
- si valuti, seppur approsimativamente, l'angolo solido
del cono del fascio luminoso
della torcia usando, al posto della calotta sferica, la base del cono; - dal flusso luminoso e dall'angolo solido calcolati nei
punti precedenti
si valuti l'intensità (media) della sorgente di luce.
- si valuti, seppur approsimativamente, l'angolo solido
del cono del fascio luminoso
- Immaginiamo che per fare una doccia sia necessario un flusso
di acqua di 10 litri/min,
che la temperatura di ingresso dell'acqua nella caldaia sia pari a 10 °C
e che quella di uscita sia di 40 °C.
Trascurando le dissipazioni termiche si valuti la potenza termica
che deve avere la caldaia per poter fornire tale flusso di acqua calda.
[Per avere un'idea di tale potenza si valuti a quante stufette 'caldobagno' da 2kW corrisponde.]
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 19 (18/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Un curioso esercizio sulle derivate (→ problema nr. 1)
- Curve di potenziale e punti di equilibrio
- Oscillazioni armoniche intorno ai minimi locali
→ caso del pendolo
→ 'buche di potenziale' - Fotometria
Problemi proposti
- Un curioso esercizio (per il momento):
data la funzione f(x,t) = A·cos(ω·t - β·x),- si calcolino le derivate seconde sia rispetto a x che rispetto a t, ovvero d2f/dx2 e d2f/dt2;
- si mostri come ω2·d2f/dx2 è uguale a β2·d2f/dt2,
- ... da cui segue, essendo ω2 diverso da zero, che d2f/dx2 è uguale a d2f/dt2 diviso (ω/β)2.
- dire 'che grandezza potrebbe essere' ω/β, ovvero quali sono le sue dimensioni fisiche.
- Lezione 20 (22/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 20 (22/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 21 (23/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 22 (29/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 23 (30/04)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
- Lezione 24 (2/05)
-
- Chiarimenti sui problemi in corso
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna su — Galleria — Home
Torna alla pagina del corso